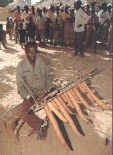Nell’antica Cina la musica era considerata arte destinata a perfezionare l’educazione dei giovani. La musica non solo aveva funzione didattica ma veniva investita di significati metafisici; era infatti considerata parte di un complesso sistema cosmologico e dalla sua perfetta esecuzione si faceva derivare il delicato equilibrio fra il Cielo e la Terra, e quindi, per estensione, la stabilità dell’Impero.
Nel
Liji "Memoriale dei riti", il sistema musicale cinese viene
spiegato in base a 5 gradi fondamentali denominati gong (palazzo),
shang (deliberazione), jiao (corno), zhi (prova), yu (ali) e viene
fatto corrispondere ad altri "gruppi di cinque", fattori
costitutivi e caratterizzanti la vita cosmica e umana. Così, per
esempio, secondo tale sistema filosofico-musicale, la nota
fondamentale gong (fa) corrisponde all’elemento terra, al punto
cardinale centro, al colore giallo, al sapore dolce, al viscere
cuore, al numero cinque, alla funzione imperatore ecc. Analogamente
la nota shang (sol) rappresenta i ministri; la nota jiao (la)
rappresenta il popolo; la nota zhi (do) e yu (re) rappresentano
rispettivamente i servizi pubblici e l’insieme dei prodotti; oltre,
naturalmente, a ulteriori parallelismi tra ciascuna nota e un
elemento, un punto cardinale ecc.
La
valenza magica attribuita ai suoni, le loro correlazioni cosmologiche
e filosofiche possono spiegare certe peculiarità della musica cinese
tradizionale; la sua lentezza e il suo mettere in evidenza la
materialità di ciascun suono, come fonte di meditazione filosofica.
Il
do, come dominante in una composizione musicale, stava a indicare che
il pezzo era stato composto per cerimonie sacrificali dedicate al
Cielo, mentre la nota re veniva impiegata nelle celebrazioni che
riguardavano gli antenati e la primavera. Il sol poteva riferirsi
soltanto a brani che concernevano la terra, mentre il la celebrava
l’equinozio d’autunno, l’imperatrice e la luna.
http://digilander.libero.it/romagnani/Storia%20pdf/terza/La%20musica%20popolare.pdf
Gli strumenti musicali cinesi, alcuni con una storia di
oltre tremila anni, si ritrovano, con piccole o grandi modifiche, in quasi
tutti i Paesi dell’Asia meridionale e del Giappone. Presentiamo alcuni di
questi strumenti che sono di uso comune sia nei concerti come nella musica di
accompagnamento dell’Opera di Pechino o del teatro classico.
Strumenti ad arco
Nella musica popolare cinese esistono diversi strumenti
cordofoni, cioè dotati di corde, classificati come "liuti ad arco". I
liuti cinesi a differenza di quelli europei sono spesso puntuti: hanno una
parte appuntita che sporge nella sezione inferiore della cassa e hanno un
manico lungo.
Erhu: è il conosciutissimo violino a due corde, come dice il
nome cinese. Ha una cassa di risonanza costruita in legno di sandalo rosso
coperta solitamente con pelle di serpente o di altri rettili. Viene suonato con
un arco diritto, molto simile a quello del nostro violino, fornito di crini di
cavallo che vengono però inseriti sotto le corde dello strumento.
Jinghu: un altro tipo di violino usato come strumento
principale nella musica dell’Opera di Pechino. molto piccolo, quasi la metà
dell’erhu, ha il risuonatore cilindrico rivestito di pelle di serpente o di
rettile e il manico o collo, in bambù. Contrariamente al suo formato ridotto il
Jinghu possiede un suono di volume sorprendente. Nell’Opera di Pechino ha la
funzione di accompagnare il canto.
Sihu: violino identico nella struttura, nel materiale e
nella forma all’erhu, eccetto il fatto di essere dotato di quattro corde invece
di due.
Banhu (板胡, pinyin: bǎnhú) : fa parte
della famiglia degli huqin. E' usato principalmente nella Cina settentrionale.
Ban significa asse di legno e hu è l'abbreviazione di huqin.
Come i più conosciuti erhu e gaohu, il banhu ha due corde,
viene tenuto verticalmente, e i crini passano tra le due corde. Il banhu
differisce nella costruzione dall'erhu per il fatto che la cassa di risonanza è
fatta in genere da una noce di cocco e invece di una pelle di serpente,
comunemente usata per coprire la superficie degli strumenti huqin, il banhu usa
una sottile lamina di legno.Il banhu è talvolta chiamato banghu, perché spesso
usato nell'opera bangzi della Cina settentrionale.
Strumenti a pizzico
Appartengono alla famiglia dei cordofoni come i precedenti,
ma vengono suonati non per mezzo di archetti ma pizzicando le corde con le dita
o con il plettro.
Pipa: il più popolare e conosciuto tra i liuti a pizzico
della musica cinese. Il manico è il prolungamento della stessa cassa di
risonanza. Ha un fondo panciuto che ricorda i nostri liuti del Rinascimento ed
è fornito di testatura, cioè di ponticelli che sorreggono quattro corde di seta
(nelle versioni moderne di metallo argentato) sul manico e sulla tavola.
Quattro sottili piroli, ai lati nella parte alta del manico, mantengono tese le
corde.
Yueqin: è la vera chitarra luna nella forma originale. Si
tratta di uno strumento a tre corde, con corpo perfettamente rotondo e piatto,
unito a un collo corto.
Ruan (阮), chiamato anche qin pipa (秦琵琶) e ruanxian (阮咸): chitarra a quattro
corde. Attualmente è usata nella musica popolare cinese, per a solo e nelle
orchestre. Nella cassa di risonanza vi sono due fori rotondi che si aprono
sulla faccia superiore. Si tratta di una chitarra baritono.
Sanxian: liuto a tre corde dal collo lungo. Ha la cassa di
risonanza formata da un cerchio ovale il legno ricoperto nelle due facce,
anteriore e posteriore, di pelle di rettile, solitamente serpente.
Le cetre (strumenti senza manico le cui corde sono tese su
tutta o quasi la lunghezza della cassa): le principali sono il qin e il zheng.
Qin: è tra gli strumenti cinesi il più studiato, in Cina e
all’estero. Ha una cassa costituita da due tavole di legno, una superiore
arcuata e una inferiore piatta. Inizialmente suonato sulle ginocchia, fu poi
posato su di una tavola. Ha un unico ponticello che regge le sue 7 corde,
tradizionalmente di seta. Si suona a pizzico con la punta delle dita e il
pollice o con il plettro.
Zheng: è una cetra a ponticelli mobili
con 13 corde. Le corde, tese su tutta la lunghezza della cassa di risonanza,
passano su singoli ponticelli che l’interprete può spostare leggermente. Le
dita della mano destra pizzicano le corde a destra dei ponticelli; l’appoggio
della mano sinistra sulla parte libera della corda, a sinistra dei ponticelli,
permette di fare vibrare e alzare l’intonazione della nota. Deriva dalla cetra
se (a 25 corde, non più in uso) e viene talvolta definita una sua versione più
piccola.
Nell’antichità la tecnica di esecuzione si distingueva
nettamente dalle altre cetra per via del bastoncino che percuoteva le corde.
Strumenti a fiato
Nella famiglia degli aerofoni, cioè di quelli strumenti il
cui suono è prodotto dalle vibrazioni dell’aria, i più usati nelle orchestre di
musica tradizionale cinese sono i flauti, le zampogne e gli organi a bocca.
Xiao: flauto diritto che vanta un’antichità di circa 3000
anni. Sotto le dinastie dei Sui (589-618) e dei Tang (618-907) era lo strumento
principale dell’orchestra. Da due secoli i più famosi Xiao sono prodotti a
Yubing nel Guizhou, ove esiste un particolare bambù che permette la costruzione
di flauti dal timbro eccezionale, inalterabili nel tempo e inattaccabili dagli
insetti.
Dizi: flauto traverso, è popolarissimo in Cina sia come
strumento per a solo che come parte integrante di orchestre. Per moltissimo
tempo costituì l’accompagnamento principale dell’Opera di Pechino. Formato da
un pezzo di bambù con otto fori. ha il secondo foro coperto da un tessuto
vegetale che rende il suo suono particolarmente dolce.
Suona: solitamente chiamato oboe cinese, ad ancia doppia, in
realtà è una zampogna spesso usata per a solo, raramente per accompagnare il
canto. Formato da un corpo centrale in legno duro, sagomato ad anelli, negli
avvallamenti dei quali sono stati fatti otto fori. Il suona è simile a molte
zampogne indiane e turche. Produce un suono forte e squillante.
Sheng: si tratta di un organo a bocca
formato da un minimo di 14 e un massimo di 32 canne di bambù, ciascuna delle
quali ha un foro. Le canne di differente lunghezza sono poste sopra un
contenitore di metallo. Il suono si ottiene soffiando aria nel
serbatoio-contenitore e regolando l’emissione nelle varie canne mediante i fori
coperti dalle dita.
Hulusi (葫芦丝)葫芦丝):
solitamente chiamato oboe cinese, ad ancia doppia, in realtà è una zampogna
spesso usata per a solo, raramente per accompagnare il canto. Formato da un
corpo centrale in legno duro, sagomato ad anelli, negli avvallamenti dei quali
sono stati fatti otto fori.









.jpg)